Lo studio delle eclissi antiche (1)

 La
prima registrazione scritta di un'eclissi di Sole viene dall'antica Cina
e compare nello Shu Ching nel quale si dice che "il Sole e la
Luna non si incontrarono in armonia".
La
prima registrazione scritta di un'eclissi di Sole viene dall'antica Cina
e compare nello Shu Ching nel quale si dice che "il Sole e la
Luna non si incontrarono in armonia".
La data tradizionalmente attribuita all'evento è quella del 22
ottobre 2134 a.C., ma, poiché il documento non ha una datazione
certa (potrebbe risalire ad un arco di tempo di circa due secoli), si tratta solo di una stima ragionevole.
si tratta solo di una stima ragionevole.
L'eclissi è associata anche alla storia degli astronomi Hi e Ho
che furono messi a morte per non essere stati capaci di prevederla e per
non aver predisposto in tempo i riti che si svolgevano durante simili
eventi:
"Qui giacciono i corpi
di Ho e Hi,
il cui fato, benché triste,
è risibile;
uccisi perché non poterono scorgere
l'eclissi che fu invisibile."
Da allora ci sono giunte diverse centinaia
di descrizioni di eventi simili, più o meno dettagliate e precise.
Queste registrazioni storiche hanno oggi un qualche valore scientifico
o le consideriamo solo per il loro valore di testimonianza?
Innanzi tutto le eclissi costituiscono uno dei pochi metodi di datazione certa degli avvenimenti che ad esse sono collegati; anzi, in molti casi la datazione delle eclissi ha anche permesso di ricostruire lo schema del calendario di antiche civiltà, rivelandosi preziosissima per gli storici.
Gli odierni strumenti di calcolo ci permettono, infatti, di trovare con approssimazioni più che buone date e circostanze (luoghi e tempi di visibilità) di eclissi di Sole avvenute migliaia di anni fa.
Ad esempio, nelle Storie di Erodoto (I,74) troviamo questo passo:
"…scoppiò una guerra fra i Lidi e i Medi che durò per cinque anni, durante i quali più volte i Medi vinsero i Lidi e più volte i Lidi i Medi; e combatterono anche una battaglia di notte. Infatti mentre essi con pari fortuna proseguivano la guerra, nel sesto anno si scontrarono, e, nel corso della battaglia il giorno all'improvviso diventò notte. Talete di Mileto aveva predetto agli Ioni questo fenomeno, indicando quello stesso anno in cui effettivamente avvenne. I Lidi e i Medi, quando videro la notte prendere il posto del giorno, cessarono il combattimento e s'adoperarono entrambi perché si facesse tra loro la pace…".
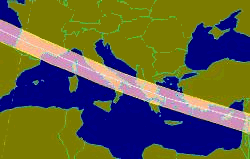 |
|
La
fascia di totalità dell'eclissi del 585 a.C.
|
Ora, da altre fonti sappiamo che il periodo
di cui si parla è collocabile intorno alla prima metà del
VI secolo a.C. Con un po' di calcoli e utilizzando qualche programma specializzato,
troviamo una quarantina di eclissi di Sole totali o quasi totali, visibili
in quel secolo dall'emisfero Nord.
Poiché gli avvenimenti di cui si parla si svolsero in Asia Minore
(l'odierna Turchia), scopriamo che da quella zona fu visibile solo l'eclissi
totale del 28 maggio 585 a.C. (verso le ore 14.43 UT, le 16.43 in ora
locale).
Siamo così riusciti a datare questo avvenimento.
Un bell'esempio di discussione sulla datazione di eclissi descritte nell'antichità
è l'articolo di F.R. Stephenson and L.J. Fatoohi, astronomi dell'Università
di Durham, Gran Bretagna, sull'eclissi totale di Sole descritta da Plutarco
nel suo dialogo "Sulla faccia della Luna" (http://www.dur.ac.uk/Classics/histos/1998/stephenson.html).
Per la cronaca, l'identificazione proposta è quella con l'eclissi
del 71 d.C. che fu totale in Grecia intorno alle 11 (ora locale).
A saper ben leggere ci sono altre informazioni utili che è possibile trarre da ricerche di questo tipo. Facciamo un altro esempio.
Lo storico Diodoro Siculo, vissuto nel I sec. a.C., racconta nella sua Biblioteca Storica la fuga di Agatocle, tiranno di Siracusa che rompe l'assedio delle navi nemiche al porto.
"Essi raggiunsero la salvezza insperatamente sul far dell'alba. Il giorno successivo ci fu un'eclissi di Sole nel corso della quale scese il buio più fitto e le stelle furono viste splendere per tutto il cielo. Gli uomini di Agatocle, interpretando l'evento come un cattivo presagio, precipitarono nell'angoscia per il loro futuro".
Qualche giorno dopo essi approdavano nei pressi di Cartagine.
Secondo Diodoro l'anno era il 310 a.C., e i nostri calcoli ci fanno identificare
l'evento con l'eclissi totale del 15 agosto di quell'anno (per inciso
questa è la prima registrazione di un eclissi totale visibile dall'Italia).
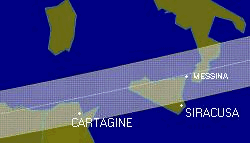 |
|
L'eclissi
del 310 a.C.
|
Ora, gli storici si sono chiesti se la rotta seguita da Agatocle fosse
verso il nord o verso il sud della Sicilia. Ebbene, la fascia di totalità
dell'eclissi passa a nord dell'isola; se il riferimento di Diodoro al
"buio più fitto" è affidabile - e non abbiamo ragione
di ritenere il contrario, vista anche la generale precisione dello storico
- possiamo dedurre che il tiranno fece rotta verso nord e attraversò
lo stretto di Messina, costeggiò la sponda settentrionale dell'isola
e poi fece rotta verso la costa nordafricana.