Fino alla fine del XVI secolo la base per
la costruzione di atlanti e carte celesti era stato il catalogo di stelle
dell'Almagesto di Tolomeo.
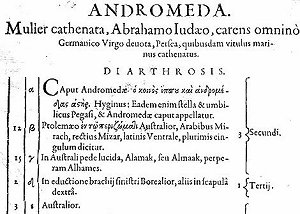 Verso
la fine del secolo due eventi di enorme importanza diedero nuovo impulso all'astronomia.
Tycho Brahe condusse una serie di osservazioni di incredibile precisione rimisurando
tutte le posizioni delle stelle del catalogo di Tolomeo e il navigatore olandese
Pieter Keyser, in viaggio dal Capo di Buona Speranza verso Java, osservò
il cielo australe componendo dodici nuove costellazioni, la prima aggiunta
alle configurazioni conosciute da oltre duemila anni. I nomi dati ad esse
erano nomi di animali esotici: Tucano, Uccello del Paradiso, Pesce volante.
Verso
la fine del secolo due eventi di enorme importanza diedero nuovo impulso all'astronomia.
Tycho Brahe condusse una serie di osservazioni di incredibile precisione rimisurando
tutte le posizioni delle stelle del catalogo di Tolomeo e il navigatore olandese
Pieter Keyser, in viaggio dal Capo di Buona Speranza verso Java, osservò
il cielo australe componendo dodici nuove costellazioni, la prima aggiunta
alle configurazioni conosciute da oltre duemila anni. I nomi dati ad esse
erano nomi di animali esotici: Tucano, Uccello del Paradiso, Pesce volante.
Con questi dati Johann Bayer pubblicò
nel 1603 ad Augsburg la sua Uranometria. Pregevole dal punto di vista
artistico, le 55 tavole sono un vero e proprio strumento di lavoro. Ogni mappa
riporta una griglia sulla quale è possibile leggere le coordinate con
la precisione di qualche frazione di grado. Bayer introdusse anche un sistema
di nomenclatura in uso ancor oggi: le stelle delle costellazioni venivano
identificate con lettere greche, in ordine di luminosità; così,
ad esempio, la stella brillante dell'occhio del Toro è alfa Tauri e la più luminosa della costellazione del Centauro è alfa
Centauri.
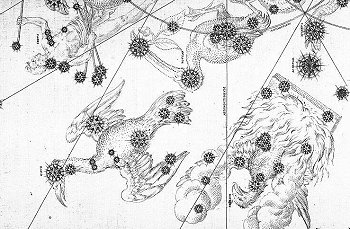
Molte delle novità nella cartografia
celeste venivano introdotte prima nella costruzione di globi che in atlanti
e carte. Il catalogo di Tycho, ad esempio, era stato utilizzato da Petrus
Plancius cinque anni prima (1598) di Bayer. Purtroppo non resta più
traccia di questi globi. Forse il miglior surrogato è il planisfero
di Andres Cellarius pubblicato nella sua Harmonia macrocosmica del
1661 (Amsterdam). Coloratissimo, se fosse avvolto su una sfera formerebbe
un globo di una trentina di centimetri di diametro, dimensione tipica per
l'epoca.
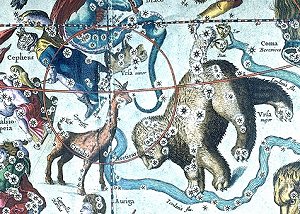
Le costellazioni aumentavano di numero.
Nel 1690 il polacco Johannes Hevelius pubblicò (Gdansk) il suo Firmamentum
Sobiescianum sive Uranographia. Sette costellazioni nuove, ma, soprattutto,
una migliore rappresentazione dell'emisfero australe. Bayer aveva usato, per
il cielo sud, le osservazioni di Keyser; Hevelius potè disporre di
quelle di Edmond Halley che nel 1676 aveva soggiornato a Sant'Elena e aveva
osservato la posizione di 341 stelle meridionali.
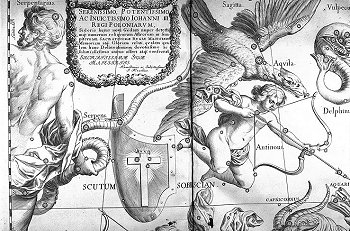
Qualche anno più tardi, il veneziano
Vincenzo Coronelli avrebbe prodotto splendidi globi celesti utilizzando l'atlante
di Hevelius come fonte principale. Coronelli, cartografo, produsse anche un
paio di atlanti piani come l'Epitome cosmografica, stampato a Colonia
nel 1693.
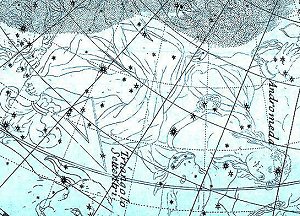
L'Uranographia di Hevelius è
dedicata a Janos Sobieski, Giovanni III Re di Polonia, al quale è dedicata
anche una delle nuove costellazioni: lo Scutum Sobiescianum.
In quell'epoca, alcuni astronomi avevano
tentato di modificare i nomi delle costellazioni, spinti da motivazioni diverse;
alcune di queste erano tributi ai monarchi e ai principi loro patroni, ma
la maggior parte divennero presto obsolete, perché non accettate dalla
comunità scientifica e quindi cadute in disuso.
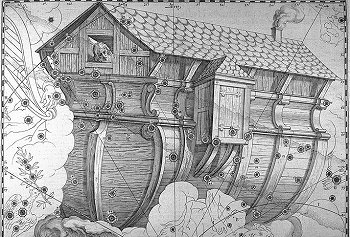
Il tentativo più radicale compiuto
in questo senso fu quello del tedesco Julius Schiller. Egli decise di sostituire
i nomi di origine "pagana" delle costellazioni con quelli di figure "cristiane";
così Cassiopeia divenne Maria Maddalena, Auriga S.Gerolamo, Perseo
S. Paolo, la Nave Argo l'arca di Noè. Il suo Coelum stellatum Christianum fu pubblicato in Augsburg nel 1627. Anche Cellarius riprese l'idea e inserì
la versione "cristiana" nell'Harmonia macrocosmica. Il tentativo però
rimase senza seguito: la forza di una tradizione millenaria si mostrò
invincibile.
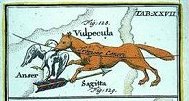 L'opera
di Hevelius generò molti altre pubblicazioni. Una delle più
belle ed interessanti fu l'Atlas portatilis coelestis di Johann Rost
(Norimberga, 1723), nel quale tavole coloratissime raffigurano le costellazioni
con poco rigore scientifico - i colori quasi nascondono le stelle - ma con
un sicuro effetto scenografico.
L'opera
di Hevelius generò molti altre pubblicazioni. Una delle più
belle ed interessanti fu l'Atlas portatilis coelestis di Johann Rost
(Norimberga, 1723), nel quale tavole coloratissime raffigurano le costellazioni
con poco rigore scientifico - i colori quasi nascondono le stelle - ma con
un sicuro effetto scenografico.
Allo stesso periodo appartiene l'Atlas
coelestis di Johann Gabriel Doppelmayr (Norimberga, 1742). Opera interessante,
più che un atlante è un testo di astronomia illustrato, come
quello di Cellarius, in cui sono presenti schemi, diagrammi e una decina di
carte e planisferi celesti.
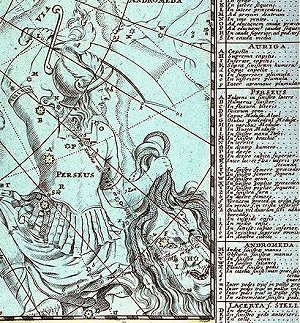
L'ultima sensibile aggiunta alla topografia
del cielo fu fatta dal francese Nicolas-Louis de Lacaille. Fra il 1750 e il
1752 egli identificò tredici nuove costellazioni del cielo australe,
misurando, dal Sud Africa, le posizioni di circa novemila stelle. A queste
costellazioni diede nomi di strumenti scientifici come telescopio, orologio,
ottante.
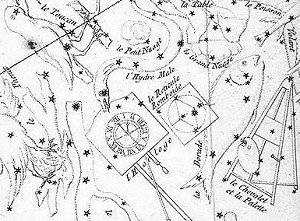
L'annuncio fu dato con la pubblicazione
nel 1756 a Parigi del Planisphere contenant les Constellations Celestes nelle memorie dell'Academie Royale des Sciences.
E' interessante notare che, fino ai primi
del 1700, nessun astronomo effettuò una campagna di osservazioni con
un telescopio, che pure aveva avuto tanta parte nelle ricerche di Galileo
quasi cent'anni prima.
Negli anni fra il 1700 e il 1720 John Flamsteed,
primo astronomo reale inglese e promotore dell'Osservatorio di Greenwich,
lavorò al suo British Catalogue of Stars, pubblicato nel 1725,
misurando con grande precisione le posizioni di oltre 4000 stelle.
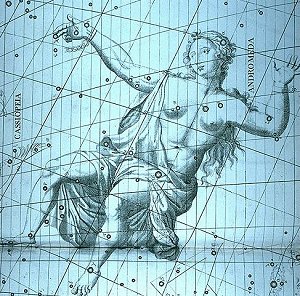
Quattro anni dopo, nel 1729, egli pubblicò
a Londra l'Atlas Coelestis: fino ad allora il testo di riferimento
era stato l'atlante di Bayer.
Il motivo principale che aveva mosso Flamsteed
a pubblicare un nuovo atlante era quello di correggere ciò che egli
riteneva l'errore più grave di Bayer. Questi aveva disegnato le costellazioni
rovesciate, mostrandole come viste dall'esterno del globo celeste; in questo
modo le posizioni non corrispondevano più alla descrizione tradizionale.
Quella che per Tolomeo era la "stella sulla spalla destra" di Orione, ad esempio,
sulle carte di Bayer era raffigurata sulla spalla sinistra. Quelle descrizioni
erano ancora molto usate e, secondo Flamsteed, il lavoro di Bayer introduceva
confusione nell'astronomia stellare.
A parte ciò, l'atlante di Flamsteed
era quanto di più preciso e completo fosse mai stato prodotto. Gli
mancava solo la qualità estetica dei lavori di Hevelius e di Bayer;
inoltre, il suo grande formato (quasi 60x50 cm) ne faceva un oggetto di difficile
consultazione. Queste "manchevolezze" furono superate
in molte delle edizioni successive, ridisegnate da ottimi artisti. La più
nota è, forse, l'Atlas celeste edito a Parigi dall'artista francese
Fortin nel 1776.
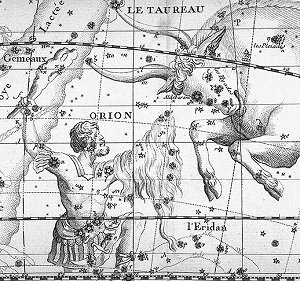
Non tutti si basarono sul lavoro dell'astronomo
reale. John Bevis, per citarne uno, propose un atlante ancora disegnato sui
dati di Bayer. Compose l'Uranographia Britannica intorno al 1750, ma
il fallimento dello stampatore ne ritardò l'uscita, che avvenne solo
dopo la sua morte, avvenuta nel 1711, in pochi esemplari; uno di questi, completo
e in ottime condizioni, è stato ritrovato nella biblioteca della Manchester
Astronomical Society nel 1998.
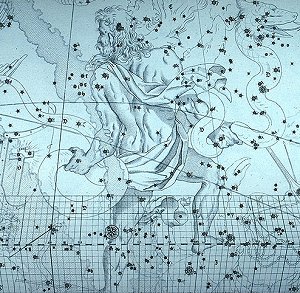
Rispetto a Bayer, l'Uranographia Britannica,
contiene più stelle, con posizioni più precise e include anche
molte stelle variabili, nebulose e alcuni degli oggetti del catalogo di Messier.
Derivazione singolare dell'atlante di Flamsteed
è il Neuster Himmels-Atlas di Christian Friedrich Goldbach (Weimar,
1799). Pensato per essere utilizzato nelle lezioni di scuole e accademie,
ha la caratteristica di essere stampato in negativo: stelle bianche su fondo
nero; inoltre, ogni carta è riprodotta due volte: una con le figure
delle costellazioni, l'altra con solo le stelle, senza figure o disegni.
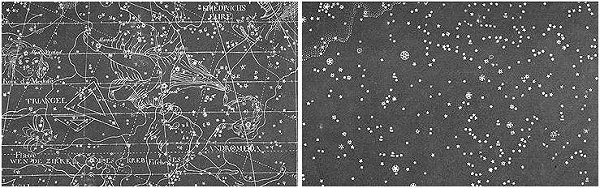
Quasi esattamente due secoli dopo l'Uranometria di Bayer, nel 1801, Johann Bode pubblica a Berlino la sua Uranographia.
E' il più grosso atlante mai prodotto:
oltre 17.000 stelle, 2.500 nebulose scoperte e catalogate da William Herschel,
tutte le costellazioni proposte fino ad allora più alcune inventate
dallo stesso Bode e delle quali si è poi perso il ricordo, come il
Pallone aerostatico, la Macchina elettrostatica o l'Officina tipografica. Le illustrazioni sono di grande bellezza e fanno buon
uso delle grandi dimensioni delle tavole dell'atlante.
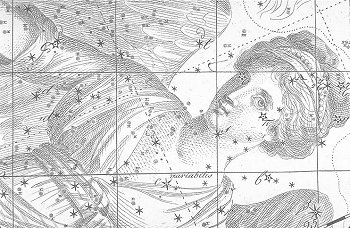
Quello di Bode è l'ultimo grande
atlante celeste illustrato con figure mitologiche e leggendarie e segna la
fine dell'età d'oro iniziata con Bayer.
Gli astronomi trovavano inopportune le
illustrazioni delle costellazioni e gli atlanti professionali cominciarono
a tralasciarle. Con telescopi sempre più potenti, gli astronomi inserivano
sempre più stelle nei loro cataloghi. Alla fine si trovò un
accordo sulla divisione del cielo in 88 costellazioni, divisione che fu poi
ratificata dalla IAU (International Astronomical Union) nel 1930 con l'adozione
delle delimitazioni di E. Delaporte del 1875.
La cartografia astronomica del XIX secolo
vede il suo più alto rappresentante in Friedrich Argelander. Il suo
atlante, del 1843, riporta ben 324.189 stelle.
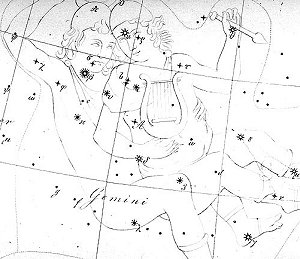
Neue Uranometrie, si chiama, quasi
a segnare una nuova epoca, come quella che Bayer aveva iniziato due secoli
addietro, con lo stesso obiettivo di disegnare tutte le stelle visibili, ma
con duecento anni di osservazioni in più. L'atlante riporta solo tenui
contorni di figure che rappresentano le costellazioni, curiosamente copie
di quelle di Bayer. Oltre a ciò nessun altro elemento "estraneo" disturba
le tavole: l'obiettivo è fornire posizioni e magnitudini con la migliore
accuratezza possibile.
Con Argelander inizia l'epoca moderna delle
rappresentazioni professionali del cielo.