Fino al XV secolo, scienziati e studiosi non
disegnarono carte complete del cielo. Con la scoperta della stampa, rappresentazioni
delle singole costellazioni cominciarono a fare la loro comparsa in alcune
pubblicazioni come il Poeticon astronomicon di Hyginus, stampato a
Venezia nel 1482.
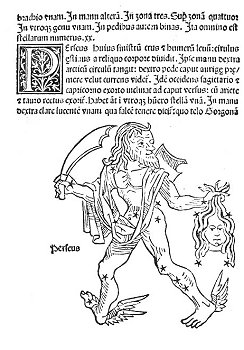
Nel 1515 Albrecht Dürer produsse a Norimberga
la prima carta completa, in due emisferi, che divenne modello ed esempio per
tutte le pubblicazioni successive.
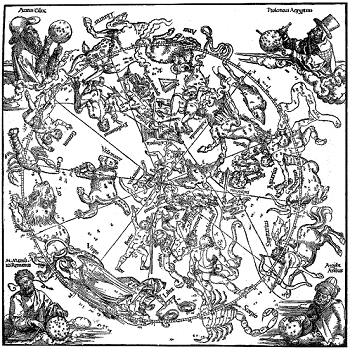
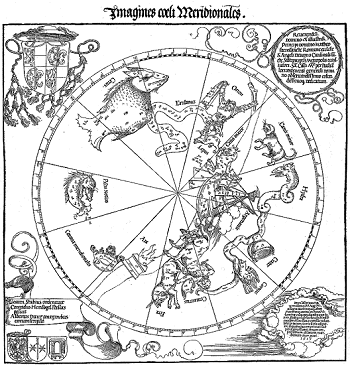
Con il risveglio degli studi di astronomia matematica
nell'Europa rinascimentale, gli scienziati dovettero cominciare a sentire
l'esigenza di avere una mappa del cielo compatta e facilmente riproducibile
con le nuove tecnologie di stampa da poco inventate, simile alle carte geografiche
che usavano esploratori e navigatori.
La fervida immaginazione dell'uomo rinascimentale
trasse alimento dalle figure mitologiche con le quali si identificavano le
costellazioni e che un artista avrebbe potuto interpretare in maniera fantastica.
Il fascino di una lettura artistica delle costellazioni influenzerà
l'immaginazione astronomica per quasi quattrocento anni e darà vita
ad una vera e propria età dell'oro per le rappresentazioni del cielo.
Fra la metà del 1500 e gli inizi del 1800,
la produzione di atlanti celesti coniuga il "rigore" scientifico con l'espressione
artistica. Il risultato è la produzione di oggetti di incomparabile
valore, fra i più bei libri che siano mai stati stampati.
De le stelle fisse di Alessandro Piccolomini,
pubblicato in Venezia nel 1540, viene considerato il primo atlante celeste
"moderno". A differenza di tutti gli altri, le carte riportano solo le stelle,
senza linee che le congiungano per mostrare le note figure delle costellazioni,
né disegni di personaggi mitologici o leggendari.
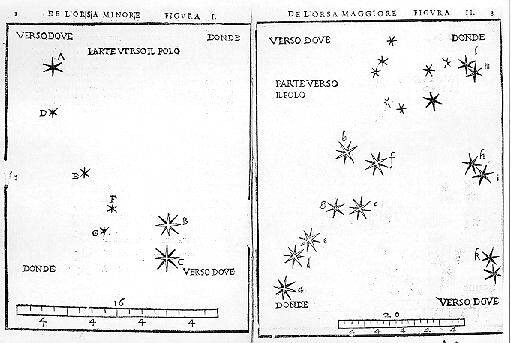
Giovanni Gallucci, invece, produce nel 1588 (Venezia)
il Theatrum mundi inserendo le stelle all'interno di figure disegnate
con uno stile tipicamente cinquecentesco.
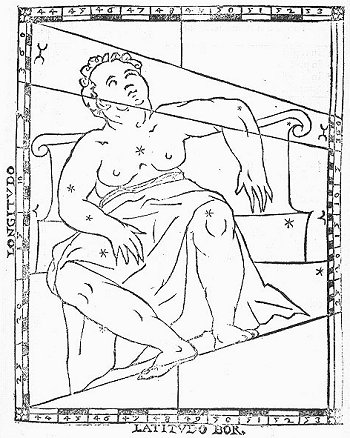
Molti degli atlanti e delle carte celesti prodotti
fra il Cinquecento e il Settecento mostrano le costellazioni "al contrario",
cioè come se fossero disegnate sulla superficie di una sfera da un
osservatore che sta all'esterno.
Si tratta, di fatto, di rappresentazioni piane
di globi celesti. Nell'Europa del Rinascimento i globi celesti, ben noti nel
mondo islamico, divennero ornamento delle biblioteche di nobili, scienziati
e studiosi; anzi, l'usanza era di avere una coppia di globi, uno terrestre
e l'altro celeste. Artisti, così è corretto chiamarli, come
Mercator, van Langeren, Hondius produssero oggetti di incomparabile bellezza.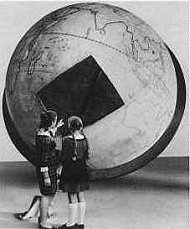
Le dimensioni erano le più diverse; alcuni
erano anche molto grandi, fino a raggiungere i tre e più metri di diametro
di quello costruito nel 1664 per il Duca Federico III di Holstein Gottorp.
Vero e proprio antenato dei moderni planetari, il globo era cavo e poteva
ospitare al suo interno fino a 10 persone che potevano così osservare
"in diretta" i movimenti della sfera celeste.
L'idea fu poi perfezionata da Charles Long che
nel 1758 costruì una sfera di 5.5 metri di diametro, su cui le stelle
avevano dei piccoli fori attraverso i quali filtrava la luce esterna. Rappresentazione
molto realistica del cielo notturno.
L'ultima sfera di questo tipo fu quella di Charles
Attwood del 1913, rimasta fino a pochi anni fa esposta alla Chicago Academy
of Sciences.